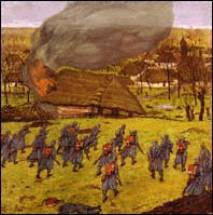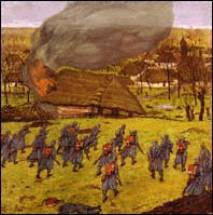|

Grosz
L’esplosione
brandello: frammento di muro, che al poeta sembra parte di un
corpo sofferente.
tanti: i numerosi amici e compagni del poeta
che con lui hanno combattuto.
corrispondevano: che ricambiavano i suoi
sentimenti di amicizia e affetto.
neppure tanto: dei suoi compagni non è
rimasto che il ricordo, poiché sono morti
nessuna croce manca: Nel cuore del poeta
c’è posto per tutti gli amici caduti
il paese più straziato: il luogo in cui la
guerra ha compiuto più disastri
Schema metrico
La
poesia è composta da quattro strofe: le prime due sono quartine, le ultime
due sono distici (solamente due versi). I versi sono irregolari, in quanto il
numero di sillabe è variabile. Inoltre i versi non presentano particolari
rime, ma all’interno di ogni strofa vi sono delle parole che si ripetono
appositamente. Per esempio nelle prime due strofe è il verbo “rimasto”,
che esprime l’amara constatazione che ciò che è rimasto delle case è
poco, ma sicuramente di più di ciò che è rimasto dei suoi amici morti al
fronte.
|
Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello
di
muro.
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce
manca.
E’ il mio cuore
il paese più straziato.
|

Lavery
Cimitero (Etaples
1919)
Considerazioni generali
Nella
raccolta “L’Allegria”, Ungaretti
si allontana dalla tradizione della poesia classica. Oltre alla
mancanza della rima e alla presenza di versi irregolari, il testo
utilizza il lessico della vita di tutti i giorni e manca, in generale,
di figure di suono e di sintassi . Il poeta utilizza un linguaggio
scarno ed essenziale per comunicare al lettore le conseguenze della
guerra, che compie le peggiori devastazioni nel cuore umano; si tratta
di un messaggio efficace anche senza fare ricorso agli ornamenti della
retorica.
L’associazione delle immagini
Il
testo propone due metafore estremamente suggestive: quella che associa
l’immagine della casa devastata a quella del corpo umano, per il quale non
è possibile la sopravvivenza quando è ridotto a brandelli e quella che
paragona il cuore del poeta ad un cimitero. L’immagine del corpo umano come
quella di un edificio è in letteratura piuttosto ricorrente, basti pensare,
ad esempio, alla villa in decadenza di cui parla Gozzano nel testo “La
signorina Felicita”, associata alla decadenza fisica ed economica della
marchesa sua proprietaria.
Tipica
invece di Ungaretti è l’associazione cuore-cimitero: il ricordo rimane per
sempre nel cuore come la croce nel cimitero. A
ben vedere però, anche questa immagine ha degli illustri precedenti
letterari; si pensi ad esempio ai testi di Foscolo
nei quali la tomba, il cimitero, diventano il luogo in cui i vivi rendono
omaggio alla memoria dei loro cari e la rendono eterna nei loro cuori.
Talvolta i morti ai quali si rende omaggio sono quelli ai quali una nazione
intera è legata da un vincolo di riconoscenza per ciò che hanno fatto: si
tratta di personaggi illustri, quelli sepolti nei cimiteri monumentali come
quello di Santa Croce a Firenze (Foscolo, I Sepolcri), ma anche gli
umili fanti caduti in trincea come quello descritto nella poesia Veglia,
che lascerà nell’animo del poeta un ricordo incancellabile.
|